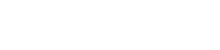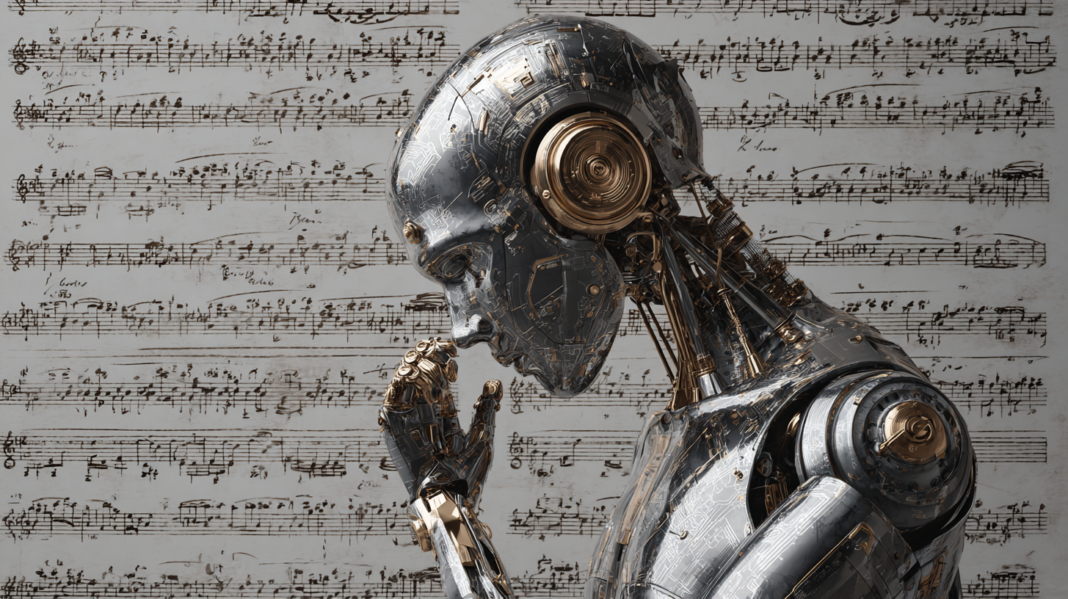Tempi di cambiamento per il settore dell’arte, in tutte le sue diverse categorie di espressione, da quando l’irrompere dell’AI nei campi della creatività umana ha reso imprescindibile porsi domande impegnative, che sfidano le nostre convinzioni più radicate e alle quali è difficile rispondere in modo sicuro. I moderni sistemi di Intelligenza Artificiale infatti, possono essere utilizzati per creare testi, suoni, immagini, che possono presentare contenuti artistici, mettendo a rischio il regime e la disciplina attuali della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, che hanno la funzione essenziale di premiare la creatività e di incentivare la produzione culturale e la sua diffusione.
Come è stato evidenziato, le tecniche di Intelligenza Artificiale possono modificare e rimettere in discussione queste finalità creando nuove opere attraverso l’elaborazione di opere già esistenti, con la straordinaria abilità di migliorarsi autonomamente, di imparare dai propri errori. Si parla, a questo proposito, di tecnologia “generativa”, cioè di una tecnologia che si modifica ed evolve man mano che viene utilizzata. E da quello che abbiamo potuto vedere in questi anni, l’evoluzione è tumultuosa e velocissima, al punto che talvolta si ha la sensazione che non sia possibile regolare compiutamente tali sistemi.
L’elemento fondamentale di tutti questi processi e tecniche computazionali è il fatto che il lavoro di queste macchine trovi il suo motore indispensabile nei dati disponibili all’interno dello sconfinato mondo del web. Un flusso inesauribile e gigantesco: basti pensare che oggi l’umanità produce in due anni la quantità di dati che abbiamo generato in tutta la precedente storia della nostra civiltà. Non è un caso che questi dati prodotti e circolanti attraverso il web e i social networks, vengano qualificati come i pozzi di petrolio del ventunesimo secolo.
Una trasformazione così repentina non si applica soltanto alla nostra società o alla nostra cultura, ma è da considerare ontologica, dunque riferita all’esistenza umana. Sempre più labile è infatti il confine che separa il mondo reale da quello digitale, e la loro complessa interazione è colta perfettamente da Alessandro Baricco nel suo “The Game”. Come osserva Alessandro Baricco in The Game (Einaudi, 2018), viviamo in “un sistema di realtà a doppia forza motrice, dove la distinzione tra mondo vero e mondo virtuale decade a confine secondario (…), producendo una trama che chiamiamo realtà”.
In questo senso, gli sviluppi dell’AI trasformano la realtà e si sovrappongono ad essa, arrivando ad incidere sulle manifestazioni più rilevanti dell’esperienza e della natura umana. Nel volume Ipnocrazia (attribuito al filosofo immaginario Jianwei Xun, pseudonimo di Andrea Colamedici), l’autore riflette su come i sistemi di intelligenza artificiale si stiano affermando come co-protagonisti della creazione culturale. Secondo questa visione, l’IA non si limita a essere uno strumento, ma diventa un agente generativo capace di produrre nuove forme estetiche e narrative, ridefinendo il confine – ormai sempre più labile – tra creatività umana e macchinica, e trasformando il modo stesso in cui percepiamo la verità e l’esperienza.
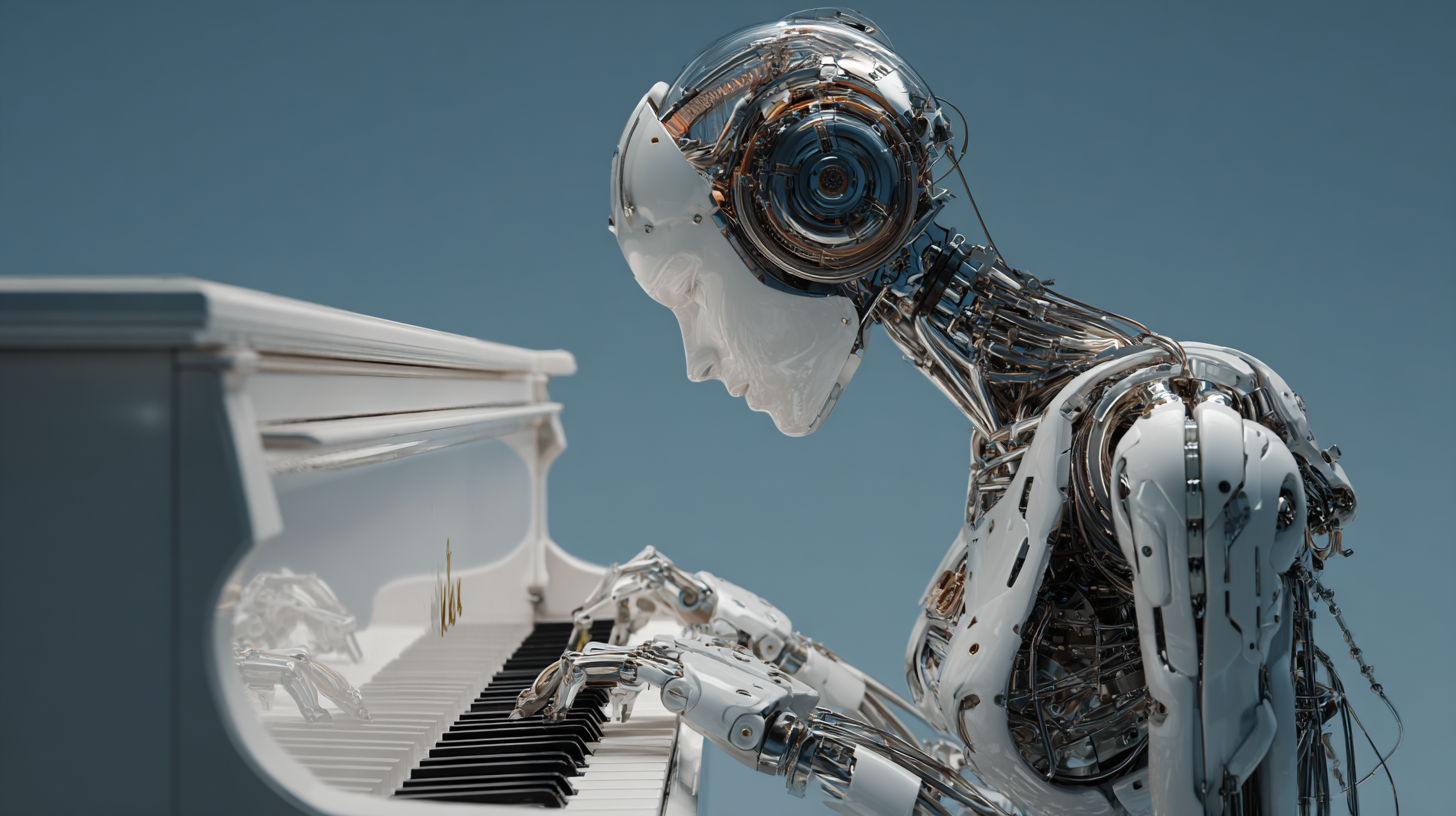
Ma possiamo parlare di vera arte, di vera creatività da parte di questi sistemi algoritmici? La macchina è consapevole di quello che sta elaborando? E soprattutto, una macchina può creare? La risposta più immediata – e forse scettica, riguardo le caratteristiche che questi sistemi di Intelligenza Artificiale potrebbero rappresentare – sta nella convinzione che l’AI lavori sulla base di materiali (appunto, nel caso della musica, parole, spartiti, suoni) che sono immessi dall’uomo e che costituiscono un input che l’attività umana mette a disposizione delle macchine. Ma in fondo anche l’attività creativa esclusivamente umana è il prodotto della conoscenza di centinaia e migliaia di attività esperite.
Sullo sfondo del pensiero creativo di un artista in qualsiasi campo ci sono le esperienze precedenti, a cui ogni artista aggiunge qualcosa, ma sempre basandosi sulla conoscenza e sullo studio delle espressioni artistiche e letterarie su cui si è formato. Questo vale per un pittore come per uno scrittore, per un poeta o per un musicista. La musica, espressione artistica su cui questo articolo si concentra, è sempre stata una forma d’arte altamente condizionata dagli sviluppi tecnologici del suo tempo. L’invenzione del fonografo, la diffusione della radio, l’emergere di nuovi modelli di creazione tramite il campionamento, l’introduzione dei CD, il download e lo streaming: tutte queste innovazioni hanno contribuito a trasformare radicalmente il modo in cui creiamo e fruiamo del suono. L’intelligenza artificiale può completamente stravolgere, e in parte già lo sta facendo, l’intera industria discografica.
Il veloce sviluppo di sistemi di AI accessibili a tutti per creare musica, ha reso molto più urgente e complesso il tentativo ancora in atto di regolamentarne la diffusione e di costruire un solido sistema normativo che tuteli la proprietà e la paternità delle opere che vengono create. App come Suno e Udio sono rivoluzionarie e allo stesso tempo motivo di grande preoccupazione da parte dell’industria musicale, poiché in grado di generare costantemente nuova musica sulla base di pochissimi input che chiunque può selezionare. Il procedimento è molto semplice: basta inserire un testo (o addirittura utilizzarne uno a sua volta creato da un algoritmo), aggiungere qualche indicazione di base sullo stile e sulle caratteristiche del brano che si vuole creare (per esempio “Pop ballad, catchy sound, male voice”), e l’applicazione restituisce una traccia audio inedita. Inoltre, l’abilità di questi sistemi di AI, sta soprattutto nel riuscire ad emulare stili o addirittura vocalità dei cantanti più celebri, rischiando di creare una replica infinita di musica senza tempo e senza arte, che può continuare a sopravvivere ed evolversi anche dopo la morte dell’artista.
Ormai noto su questa specifica tematica, è lo scontro tra la RIIA (Recording Industry Association of America) e il programma Voicify.ai, creato da uno studente di informatica britannico, per la realizzazione di cover con intelligenza artificiale, grazie a modelli vocali spaventosamente simili ad alcuni tra i più celebri artisti e non solo: Michael Jackson, Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift, Elvis Presley, Bruno Mars, Eminem, Harry Styles, Adele, Ed Sheeran, oltre a personaggi politici tra cui Donald Trump, Joe Biden e Barack Obama. L’associazione (RIIA), che rappresenta alcune tra le più importanti etichette discografiche statunitensi, già in un rapporto del 2023 citava tale piattaforma, indicandola come “simbolo di un utilizzo improprio e illegale di diritti d’autore degli artisti e di altri diritti connessi, e dunque nemico pubblico numero uno dell’intera industria discografica”.
Doveroso citare inoltre, la protesta “silenziosa”, ma non per questo meno potente, condotta nella primavera di quest’anno da oltre un migliaio di musicisti britannici (spiccano nomi come Damon Albarn, Kate Bush, Annie Lennox, Jamiroquai, Billy Ocean e tanti altri). Alcuni di questi artisti hanno rilasciato un album dal titolo Is this what we want? (E’ questo ciò che vogliamo?), che ha fatto molto parlare di sé, pur non contenendo parole né musica; si tratta infatti di 12 tracce di puro silenzio. Dietro tale protesta, c’è la proposta avanzata dal governo del Regno Unito di modificare la normativa sul copyright, con l’obiettivo di agevolare l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. In particolare, si vorrebbe introdurre un’eccezione che permetterebbe alle aziende del settore di utilizzare contenuti coperti da diritto d’autore per addestrare i propri sistemi, a patto che tali materiali siano stati ottenuti in modo legale. Come? Attraverso un meccanismo di opt-out, che chiede agli autori di bloccare esplicitamente l’impiego delle proprie opere nei dataset di training. Vale a dire che le opere sono liberamente utilizzabili fino a nuove disposizioni, fino a quando l’autore non dice espressamente “no”. Come riporta Reuters, le modifiche proposte «richiederebbero ai creatori di attivarsi proattivamente per escludere le proprie opere, altrimenti utilizzabili”»
Il governo britannico giustificava questa scelta con l’intento di promuovere l’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale e di trasformare il Paese in un punto di riferimento per lo sviluppo del settore. Dall’altro lato, la scelta di una protesta “silenziosa” da parte degli artisti, non era casuale, dato che come sostengono tutt’ora, il silenzio è l’effetto che potrebbe generare tale proposta di legge, compromettendo la possibilità di costruire una carriera musicale sostenibile, e stravolgendo i tradizionali principi del copyright.
Le principali piattaforme di streaming già si stanno muovendo per far fronte a queste problematiche, Spotify per esempio, ha dichiarato di aver rimosso in un anno oltre 75 milioni di brani creati artificialmente. Ma il problema non è solo di tipo quantitativo, questo “overbooking” di contenuti consuma la fiducia del fruitore di musica e può trasformare ciò che è suono in rumore. Per questo Spotify introdurrà nelle prossime settimane secondo quanto dichiarato, nuove misure per regolare la produzione e l’ascolto di musica artificiale: l’obbligo di comunicare in maniera chiara nei crediti, l’eventuale impiego dell’AI e in quale percentuale, l’utilizzo di strumenti più sofisticati nell’individuazione di deepfake vocali, e accurati controlli generali sui metadati.
Eppure, dietro queste misure restrittive, ci sarebbe anche una possibilità di compromesso. Si parla di trattative per licenze – come l’esempio prima accennato riguardante la proposta di legge del governo britannico – che permetterebbero alle startup di utilizzare suoni, musica, ritmi già esistente per la creazione di nuova musica, in maniera regolamentata. Un processo molto simile a quello che ha portato lo streaming a evolversi, dai primi sistemi pirata di file sharing (Napster), a una piattaforma regolamentata come Spotify: un passaggio che riscrisse le dinamiche del mercato e del consumo di musica. Oggi proprio tale piattaforma, pioniera e protagonista nella distribuzione musicale, mira a regolamentare l’utilizzo dell’AI che ormai abita prepotentemente le nostre vite, senza però frenarne gli sviluppi.

Come ha sottolineato Enzo Mazza, CEO di F.I.M.I., durante il webinar “Generative AI & Music” organizzato nell’ambito della Milano Digital Week insieme ad Abbas Lightwalla (Director of Global Legal Policy, IFPI), l’obiettivo delle nuove politiche è quello di assicurare agli artisti un reale controllo sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle loro opere. Mazza ha evidenziato come sia necessario promuovere un ecosistema musicale trasparente ed equo, in linea con i principi dell’AI Act europeo, che pone grande attenzione alla trasparenza dei processi di addestramento delle piattaforme basati su contenuti protetti da copyright.
L’obiettivo non è quello di imporre un divieto assoluto nei confronti della musica generata dall’AI, ma di tutelare ciò che nasce da un atto creativo umano, differenziandolo da ciò che è prodotto impiegando un algoritmo. Difendere dunque la dignità della musica – in ogni sua forma – come linguaggio culturale universale. In questo senso, è importante che la recentissima legge n. 132 del 2025 abbia modificato l’art. 1 della legge sul diritto d’autore stabilendo che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore” .
In altre parole, un’opera creata con l’ausilio di sistemi o tecniche di IA può essere considerata protetta dal diritto d’autore solo per quella parte in cui è il frutto di contributo umano sostanziale e verificabile.