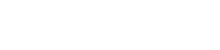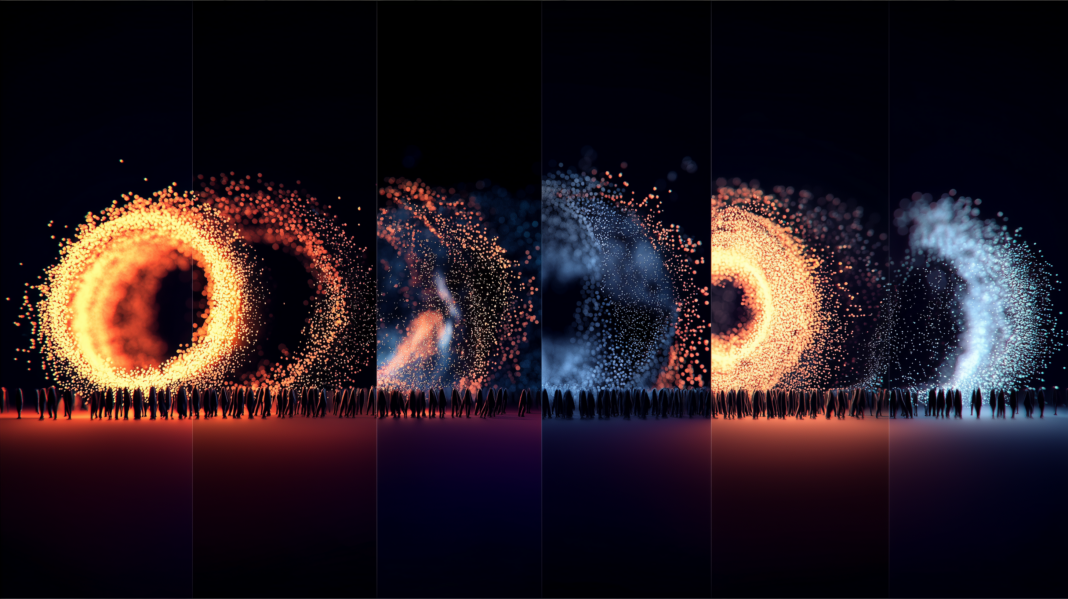articolo di Dario Buratti
La Fragilità del Mito dell’Originalità
Per secoli il mondo dell’arte ha propagato una verità-farsa: l’originalità, intesa come unicità inimitabile, sacra e portatrice di prestigio. Le opere venivano adorate come reliquie, prodotte dal genio di un autore eccezionale, quasi come se fossero frutto di un’ispirazione divina. Tuttavia, questa concezione è da sempre fragile, poiché l’unicità si rivela una chimera costruita su modelli interiorizzati dall’artista – variazioni di idee e forme preesistenti, estetiche ricontestualizzate e adattate per dar vita a opere che, per quanto possano apparire geniali, restano in realtà riedizioni filtrate di un archivio culturale.
Con l’avvento dell’arte generativa, l’intelligenza artificiale non “crea” opere nel senso tradizionale; essa scatena un vero terremoto creativo, un ecosistema di mutazioni incessanti e imprevedibili. Ogni produzione non è semplicemente un’idea geniale e originale, né una mera copia slavata: è un ibrido ribelle che infrange i confini dell’arte classica. L’artista, da garante di un’idea immutabile, si trasforma nel progettista di un processo dinamico in cui ogni iterazione non solo sfida, ma decostruisce e ricostruisce i concetti tradizionali di autenticità.
La Copia come Manifesto della Generatività
La copia, storicamente disprezzata come imitazione sterile e priva di valore, diventa ora il manifesto epocale della generatività. Non più simulacro orripilante, essa incarna la trasparenza e la radicalità di un mondo in cui ogni ripetizione porta con sé una scintilla di innovazione. Il “vero” originale non è altro che il primo anello di una catena infinita di derivazioni: una formula idealizzata che si dissolve di fronte alla molteplicità trasformativa.
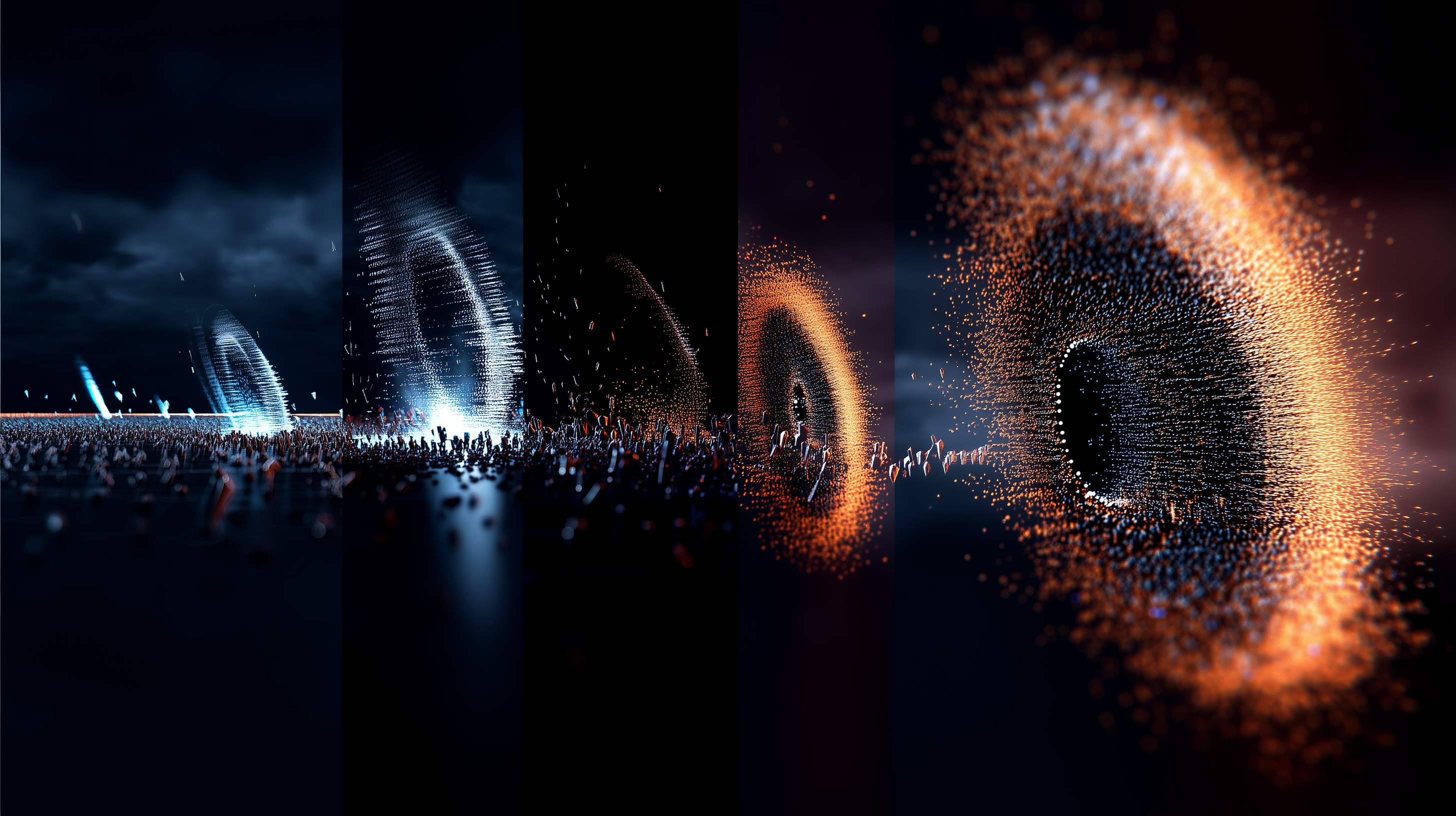
La più audace delle provocazioni emerge nello smascherare l’intero dogma dell’originalità, pilastro ormai obsoleto della modernità artistica. L’unicità, alimentata da presunti momenti di ispirazione divina, si rivela invece il prodotto di meccanismi precostituiti – modelli interiorizzati e reinterpretati in chiave continua. In “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Walter Benjamin denuncia come l’aura dell’opera, simbolo del suo status irripetibile, si eroda nel contesto della riproduzione, anticipando una dinamica simile a quella dell’arte generativa. Allo stesso modo, Roland Barthes, in “La morte dell’autore”, ci invita a disfare il mito del genio creativo, sostenendo che il significato di un’opera emerga dalla sua ricezione e dalle molteplici interpretazioni, piuttosto che dall’origine incontaminata dell’idea.
Questi concetti vengono ulteriormente approfonditi da Gilles Deleuze in “Differenza e ripetizione”, dove la ripetizione non è vista come una mera replica, ma come un processo in cui ogni reiterazione apporta nuance e trasformazioni inedite. L’idea si fonde con la visione di Lev Manovich in “The Language of New Media”, che evidenzia come i nuovi media e la tecnologia digitale abbiano radicalmente modificato la concezione del fare arte, sostituendo il concetto statico di originalità a favore di sistemi iterativi e dinamici.
Dalla Strategia Elitista alla Democratizzazione del Creato
Il sistema tradizionale, che un tempo esaltava il paradigma dell’opera irripetibile, si rivela invece una strategia ideologica tesa a limitare il potenziale creativo e a perpetuare una visione elitista dell’arte. E oggi il valore artistico non risiede più nella creazione di entità immutabili, ma nella capacità di generare infinite varianti che si moltiplicano e si trasformano, sfuggendo al controllo dell’autore e abbattendo gerarchie arcaiche. Matt Pearson, in “Generative Art: A Practical Guide Using Processing”, dimostra concretamente come la ripetizione non sia sinonimo di copia sterile, ma un metodo per dare vita a opere in costante evoluzione. Parallelamente, Hito Steyerl in “In Defense of the Poor Image” sottolinea come l’avvento delle immagini digitali e la loro riproducibilità abbiano democratizzato l’arte, trasformando ogni copia in una fonte di nuove interpretazioni.
La vera arte non è più una statua incisa nel marmo del tempo, ma un campo di battaglia in continuo divenire, dove la copia – lungi dall’essere condannata – viene celebrata come il gesto creativo più audace e trasgressivo. Questa visione, supportata da pensatori e teorici di spicco, invita a ripensare radicalmente il valore dell’originalità, aprendo la strada a una concezione dell’arte in cui la trasformazione e l’iterazione sono protagoniste indiscusse.
Riferimenti:
- Walter Benjamin – “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”
Puoi consultare la pagina di Wikipedia in italiano, che offre una panoramica sul saggio e sulla sua importanza critica:
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica - Roland Barthes – “La morte dell’autore”
Due versioni sono disponibili:- In italiano: La morte dell’autore (Wikipedia, IT)
- In inglese: The Death of the Author (Wikipedia, EN)
- Gilles Deleuze – “Differenza e ripetizione”
La versione italiana su Wikipedia offre un’ottima sintesi dell’opera e del suo impatto filosofico:
Differenza e ripetizione - Lev Manovich – “The Language of New Media”
La pagina inglese di Wikipedia descrive il libro e il suo ruolo pionieristico nello studio dei nuovi media:
The Language of New Media - Matt Pearson – “Generative Art: A Practical Guide Using Processing”
Se ti interessa dare un’occhiata ai dettagli del libro (ad esempio, a scopo d’acquisto o per leggere la descrizione completa), questo link al listing su Amazon può essere utile:
Generative Art: A Practical Guide Using Processing (Amazon) - Hito Steyerl – “In Defense of the Poor Image”
Per approfondimenti sull’idea della “poor image” e sulla critica di Steyerl al culto dell’immagine perfetta, consulta questo articolo sul sito e-flux:
In Defense of the Poor Image (e-flux)